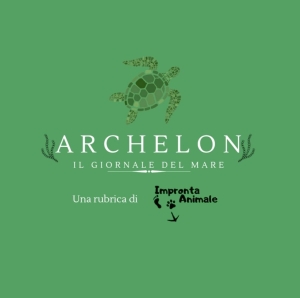"Colpa" delle Tartarughe Marine?
In data 01/02/2023 il quotidiano La Nazione è uscito con l'articolo che potete leggere in forma estesa al link seguente https://www.google.com/amp/s/www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/paletti-dellarpat-al-ripascimento-la-colpa-e-delle-tartarughe-marine-1.8494889/amp
L'articolo, di per sé corretto, sceglie di dare un taglio che noi non condividiamo ad una notizia che in qualche modo riguarda le tartarughe marine e le loro deposizioni nel tratto di costa più settentrionale della Toscana.
Essendoci occupati in prima persona, a supporto del WWF, di quei nidi e conoscendo quindi in maniera diretta quella situazione, vorremmo approfondire la questione e lasciare un nostro commento ad articoli del genere.
IL FATTO:
1) un soggetto chiede autorizzazione alla Regione Toscana per un intervento di ripascimento su un tratto di costa del comune di Massa, specificando nel progetto quali saranno i materiali e la metodologia che utilizzerà.
2) Regione Toscana chiede parere tecnico ad Arpat.
3) Arpat nell'istruttoria non può non tenere presente e menzionare che in quella zona l'anno passato ci sono state 3 nidificazioni accertate di tartaruga marina. Ma questo è solo uno degli elementi su cui si basa per esprimere il parere, in una relazione più ampia che prende in considerazione un insieme vasto di altri aspetti sui quali un eventuale ripascimento potrebbe impattare, analizzando tutte le criticità possibili (che però magari risultano meno interessanti nel racconto che il giornalista vuole fare al pubblico e nella chiave di lettura che vuole che esso abbia)
4) Fine della storia: il ripascimento verrà fatto. Quindi di fatto l' operazione NON E' BLOCCATA in alcun modo da queste circostanze (anche questo non è ben chiaro leggendo l'articolo)
Ovviamente Regione Toscana in questa sua determina non può esimersi dal dare alcune indicazioni su come debba essere svolto il lavoro sulla base di quanto osservato e riportato da Arpat e quindi anche sulla base del fatto che questo tratto di costa è stato interessato da nidificazioni di tartarughe marine.
In questo senso le uniche due indicazioni date (che nell'articolo vengono definiti ad hoc dei "paletti") sostanzialmente sono:
- evitare di svolgere le operazioni durante la stagione balneare che coincide con la stagione riproduttiva della tartaruga marina. Ma per quanto riguarda il periodo dei lavori è lo stesso proponente che evidenzia come questi siano previsti entro l'inizio della stagione, come è logico che sia, non tanto in considerazione dell'attività riproduttiva della tartaruga ma più che altro compatibilmente proprio con l' attività dei balneari.
- la spiaggia realizzata dovrà conservare le caratteristiche più naturali possibili, quindi essere composta di sabbia e avere una pendenza graduale. Quindi si chiede di evitare quanto più possibile,di utilizzare materiali provenienti da terra (non di origine marina) come materiale di cava o ghiaia, con una granulometria troppo diversa da quella da quello della sabbia. Ci pare ovvio come quanto chiesto dalla Regione sia mirato ad avere infine una spiaggia di qualità migliore anche per la balneazione.
Inoltre risulta evidente a tutti che una spiaggia erosa non è certo accogliente neanche per questi splendidi animali che stanno ampliando il loro areale di nidificazione. Questo sposta completamente il punto di vista: l'erosione costiera è un problema per l'uomo come per la tartaruga marina. Il ripascimento può essere addirittura favorevole alla nidificazione della specie dove il tratto di costa non esiste più o è gravemente rimaneggiato. Che poi si debba farlo con tutti i crismi, dallo studio della morfologia della spiaggia all'analisi della granulometria della sabbia, all'analisi del materiale che viene utilizzato è fondamentale, non è un paletto ma ciò che serve ad armonizzare certi interventi con la presenza di specie particolarmente protette come la tartaruga marina. Viepiù la presenza della tartaruga e dei suoi nidi in alcuni casi può essere addirittura propizia ad alcuni interventi, cioè grazie ad essa si può spingere verso un ripascimento, naturalmente se fatto con le dovute attenzioni.
Alla luce di quanto detto finora, l'articolo scritto dalla Nazione ci lascia piuttosto esterrefatti, il taglio che è stato dato a questa notizia effettivamente pare voler demonizzare la specie che tutti quanti, con grande sforzo, cerchiamo di tutelare, peraltro in un' area, quella della litorale della Toscana settentrionale in cui la nidificazione è un fenomeno nuovo, al quale i balneari ancora si devono abituare e dove quindi sarebbe ancor più necessaria una campagna di sensibilizzazione.
Ci pare piuttosto irresponsabile creare dei titoli in prima pagina in cui le tartarughe sono definite ostacolo alla stagione balneare o in cui si dice che è colpa delle tartarughe se non si può effettuare il ripascimento richiesto, necessario al buon andamento della stagione stessa. Ripascimento che, ribadiamo ancora una volta per chiarezza, E' STATO AUTORIZZATO.
Non vogliamo assolutamente mettere in dubbio la buona fede del giornalista o del titolista ma poiché da molti anni ci occupiamo di tutela e conservazione della tartaruga marina vogliamo testimoniare che a volte il danno maggiore per una specie protetta è proprio una mala informazione che crea ostilità nei confronti della stessa e vanifica tutti gli sforzi che gruppi come il nostro fanno da anni per garantirne la convivenza con l'uomo ed evitarne quindi la scomparsa.
A nostro parere il messaggio da trasmettere è quello che più che un ostacolo la presenza della tartaruga marina è un valore aggiunto per la spiaggia di Marina di Massa, e il suo ritorno in futuro certificherà il benessere del suo litorale
Chiediamo quindi da parte della stampa minore superficialità e maggiore responsabilità nel trattare certi temi e nel riportare certe notizie in un momento storico in cui l'attenzione nei confronti dell'ambiente è ormai universalmente ritenuta prioritaria per il bene del pianeta e quindi per il bene degli uomini.
Archelon - Plastic Sea
Plastic-sea: un mare pieno di plastica
Siamo diventati una forza della natura capace di influenzare la storia evolutiva del pianeta, come sosteneva Crutzen? Fu proprio questo scienziato, premio Nobel per la chimica nel 1995, a lasciarsi sfuggire per primo il termine Antropocene durante una pacata discussione fra colleghi. Ciò accadde nel febbraio del 2000 durante un convegno in Messico.
Gli scienziati presenti stavano discutendo degli impatti sull'ambiente causati dall'umanità nel corso dell’Olocene (l'epoca geologica dal clima mite e stabile cominciata al termine dell'ultima glaciazione, durante la quale le attività umane hanno esercitato un impatto sempre più profondo sul paesaggio e sugli ecosistemi), quando il chimico olandese si intromise nella discussione ed esclamò, zittendo i presenti: "Basta parlare di Olocene, ormai siamo nell'Antropocene!"
Per sostenere formalmente una teoria del genere sarebbe sufficiente che le alterazioni causate dalle attività umane siano ancora riconoscibili nella stratigrafia della Terra tra milioni di anni. E questo è purtroppo verosimile.
In realtà, forse, abbiamo già lasciato più di un'impronta indelebile nella geologia del Pianeta. Un primo marcatore dell'Antropocene potrebbe essere proprio la PLASTICA, una classe di materiali artificiali in grado di restare molto a lungo nell'ambiente.
La plastica
Chi al giorno d’oggi non fa uso di plastica? In un certo modo, pur volendo, risulta molto difficile riuscire a comprare qualcosa senza comprare anche della plastica. Scoperta nel 1907, dal secondo dopoguerra in poi, l’utilizzo della plastica è diventato sempre più di forte; economica, resistente e versatile, ha trovato facile applicazione in diversi campi, a partire dai mezzi di trasporto ad arrivare ai vestiti e, addirittura, ai cosmetici.

- Le confezioni in plastica vengono utilizzate anche quando superflue
Ad oggi, purtroppo, l’uso di questo materiale è diventato smodato. Basti pensare anche alla semplice vita di tutti i giorni: un caffè alle macchinette, un pasto pronto comprato al bar o al supermercato, uno snack mangiato a merenda. Questi sono solo alcuni degli esempi più comuni che ogni giorno ci si propongono. Ma, mentre questi usi sono ancora comprensibili ma non giustificabili, non sono comprensibili quei casi che capita di vedere a volte sul web, stiamo parlando della frutta monoporzione, in cui kiwi e frutta sono imballati singolarmente nella pellicola, o di quegli eventi pubblici in cui vengono rilasciati palloncini in aria. Ma dove finiscono poi questi palloncini? Come la maggior parte della plastica, in mare.
Un mare di plastica
Il 98% della plastica che finisce in mare, infatti, proviene dalle attività svolte sulla terraferma. La maggior parte di queste viene introdotta in maniera involontaria, tramite smaltimenti scorretti dei rifiuti; questi poi, attraverso processi di degradazione, si sgretolano in particelle più piccole, le microplastiche (sono così definiti i frammenti con dimensioni al di sotto dei 5mm), che prendono il nome di microplastiche secondarie.

- Da plastica a microplastica
In altri casi, invece, l’introduzione delle microplastiche è del tutto volontaria: queste vengono aggiunte soprattutto nei prodotti di cosmesi, come ad esempio gli scrubs esfolianti, e vengono definite microplastiche primarie. Essendo questi prodotti per la cura personale, per la maggior parte vengono dilavati all’interno di scarichi di lavandini, finendo direttamente nei nostri mari!
Per via dell’introduzione così massiccia di plastica all’interno dei nostri oceani, si parla di zuppa di plastica, quando si pensa all’accumulo di questa sostanza in particolari zone degli oceani, e di Plasticene, termine con cui è stata definita quest’ultima parte dell’Antropocene, che ha avuto inizio a metà del Novecento con l’aumento dell’inquinamento e del consumo di plastica.Infatti, in meno di un secolo abbiamo fabbricato oltre 10 miliardi di tonnellate di plastica e quella che si accumula sui fondali oceanici appare destinata a formare uno strato ben riconoscibile.Tale consumo è destinato ad aumentare, tant’è che è stato previsto che nel 2040 la quantità di plastica nei mari supererà in massa quella degli organismi che li popolano!
A plastic fish in a plastic world
A proposito di questi organismi, la prospettiva di essere superati in massa dalle plastiche non è l’unico pericolo a cui sono esposti; infatti, sia macro che microplastiche rappresentano un rischio per la loro sopravvivenza. Solitamente la plastica di grandi dimensioni, se ingerita, può causare soffocamento, occlusione dello stomaco o problemi di malnutrizione perché alterano il funzionamento del tratto intestinale. Inoltre, possono essere causa di deformazioni fisiche: quella che vedete nella foto seguente è una tartaruga marina (Eretmochelysimbricata) recuperata recentemente da Fundaciòn Tortugas del Mar, il cui carapace ha subito una deformazione per via della compressione esercitata dalla fascia di materiale plastico.

- Eretmochelys imbricata con deformazione. Foto di Fundaciòn Tortugas del Mar e Caretta Calabria Conservation
Per quanto riguarda le microplastiche, invece, esse possono essere facilmente ingerite, rimanere all’interno dell’individuo e, nel caso di organismi femminili, essere trasmesso anche alle uova che dovranno essere fecondate (questo, purtroppo, è stato riscontrato anche nella placenta umana).
La plastica, inoltre, può essere veicolo di altre sostanze inquinanti, che possono comportarsi da interferenti endocrini (ovvero possono essere scambiati per alcuni ormoni che regolano il funzionamento del corpo) e causare tutta una serie di altri problemi.
Cosa possiamo fare?
Ora magari, quando andremo al supermercato, faremo un po’ più attenzione al fatto se la confezione del pacco di pasta è in plastica o di carta e preferiremo comprare la frutta e la verdura sfusa, piuttosto che quella già confezionata. E già solo questo sarebbe un bel passo avanti! Ma non basta. Le azioni che si possono fare per ridurre il consumo di plastica sono diverse e qui di seguito ve ne elenchiamo alcune!
Guardandoti in casa probabilmente avrai già notato diversi contenitori in plastica, soprattutto nel bagno: shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, spazzolino, cottonfioc e tanto altro! Sul mercato, soprattutto quello online, è facile trovare prodotti naturali (quindi senza microplastiche aggiunte) e anche senza imballaggi in plastica (come shampoo, bagnoschiuma e sapone solidi), o ancora, prodotti fatti con materiali alternativi, come spazzolini o cottonfioc in bambù! Per cui una buona pratica sarebbe quella di scegliere tali prodotti piuttosto a quelli “tradizionali”.
Un’altra buona pratica sarebbe quella di ridurre il consumo di bottiglie di plastica. L’Italia, infatti, rappresenta il primo Paese nell’Unione Europea e il secondo nel mondo, a consumare il maggior numero di bottiglie in plastica, quando rappresenta uno dei primi Paesi con l’acqua potabile migliore. Ma se passare all’acqua potabile al momento non ti entusiasma più di tanto, già solo passare all’uso di borracce anziché comprare bottigliette è un grande passo!
Partecipa agli eventi di clean up! Partecipare a questi eventi ti darà davvero la dimensione di cosa finisce in mare o nell’ambiente in generale. Ti permetterà di fare nuove conoscenze e di constatare che non sei da solo in questa lotta.
Infine, ma non meno importante, elimina o almeno riduci il consumo di plastica monouso: molta della plastica che si usa ha una vita molto breve, basti pensare alle cannucce! Ad oggi, se proprio si vogliono usare stoviglie monouso, esistono fatte di cellulosa, che permettono una scelta molto più ecosostenibile.

- Eventi di clean up per rimuovere i rifiuti dall'ambiente
Per cui, come vedi, sono tante le azioni tramite cui anche tu, nel tuo piccolo, puoi aiutare! E non dimenticare, che l’azione migliore di tutte da poter fare è comunicare e condividere con gli altri queste informazioni!
Sitografia:
- https://worldrise.org/wp-content/uploads/2021/01/Libretto_Plastica.pdf
- https://www.istituto-oikos.org/static/sito/landing/mare_in_classe/allegati/cosa-dice-la-scienza/5_Un%20mare%20di%20plastica.pdf
- https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-002-En.pdf
- https://holdnorgerent.no/wp-content/uploads/2020/03/IUCN-report-Primary-microplastics-in-the-oceans.pdf
- https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20181005STO15110/plastica-negli-oceani-i-fatti-le-conseguenze-e-le-nuove-norme-infografica
Buon Anno!
Lo staff di tartAmare augura a tutti un felice anno nuovo!
Che questo 2023 possa portare a tutti felicità e tanta consapevolezza in più per la salvaguardia nel nostro meraviglioso pianeta.
Intervista a Francesco Tiralongo - Lo Scienziato che Studia gli "Alieni"
Lo scienziato che studia gli alieni.
Il Mar Mediterraneo (come già detto nell’articolo Alien fish) si sta scoprendo sempre più invaso da quelle specie definite aliene, ovvero organismitrasportati dall’uomo in modo volontario o non volontarioal di fuori del loro areale naturale. Ma cosa sappiamo noi di loro? Come interagiscono con le specie autoctone nell’ecosistema Mediterraneo? Quali impatti creano?
Per rispondere a tutte queste domande, abbiamo deciso di intervistare il dottore Francesco Tiralongo, docente di zoologia e ricercatore all’Università di Catania, che studia le specie ittiche, il loro sfruttamento e la loro biologia, oltre che le invasioni biologiche in ambiente marino Mediterraneo.

1. Francesco Tiralongo
Ciao Francesco. Visto il tuo forte interesse verso le invasioni biologiche, ti va di raccontarci qualcosa riguardo il progetto AlienFish?
Sì, certo. AlienFish è nato nel 2012, all’interno di Ente Fauna Marina Mediterranea, un’associazione che abbiamo fondato ad Avola nello stesso anno e che nel tempo si è allargata con nuove delegazioni in altre regioni, quali Campania, Lazio e Sardegna. Inizialmente arrivavano segnalazioni sporadiche per il progetto, ora, invece,AlienFish è cresciuto molto e sempre più spesso veniamo contattati da parte di pescatori, subacquei e appassionati di mare, dai quali raccogliamo dati.Inoltre, è seguito da ricercatori appartenenti a diversi enti di ricerca nazionali. Attualmente stiamo lavorando sui dati 2020-2021, dove abbiamo raccolto oltre 400 segnalazioni valide (che sono state opportunamente controllate e filtrate) di specie ittiche aliene e rare. Abbiamo, infatti, già pubblicato due report importanti nel 2019 e 2020, ora speriamo di poter inviare e pubblicare questo nuovo report che non includerà i dati del 2022, che sono ancorain fase di raccolta.
È senza alcun dubbio un progetto molto importante ed interessante, che ci permette quindi di capire quali specie sono presenti e dove, ma anche con quale frequenza. Ma chi può parteciparvi?
Ormai a questo progetto partecipano in tanti, oltre ai pescatori di professione, ci sono molti cittadini che grazie al Citizen Science riescono a darci le loro segnalazioni. Ovviamente, vi è anche il coinvolgimento di diversi ricercatori e studenti di biologia marina, o anche solo di persone di altri ambiti ma che sono appassionate del mare. Partecipano poi affiliazioni come il WWF e il CNR. Quindi possiamo dire che siamo abbastanza presenti a livello nazionale e ciò ci permette di monitorare in maniera continua la presenza e l’abbondanza di specie aliene e rare nei mari italiani. Quello che possiamo dire, come è scritto anche nell’ultimo report del 2020, è che se consideriamo solo ed esclusivamente le specie ittiche, i mari italiani si ritrovano in una situazione diversa da quella, ad esempio, della vicina Grecia. Infatti, in quest’ultimo luogo abbiamo ad esempio il pesce scorpione (Pteroismiles) e il pesce palla maculato (Lagocephalussceleratus) che sono diventati talmente abbondanti da manifestare, appunto, un vero e proprio carattere invasivo. Mentre queste stesse specie nei nostri mari si vedono ancora raramente, soprattutto il pesce scorpione.

- Pesce scorpione a sx, pesce palla maculato a dx. (Wikimedia commons).
Quindi in Italia quali sono le specie ittiche aliene più frequenti?
Nei nostri mari sono essenzialmente quattro. In primis abbiamo il pesce flauto (Fistulariacommersonii) che ha conquistato l’intero Mediterraneo, mentre inizia a vedersi con una crescente frequenza il pesce coniglio scuro (Siganusluridus). Abbiamo poi, con un’abbondanza ancora piuttosto bassa, il pesce palla maculato (Lagocephalussceleratus), infine abbiamo il monacanto reticolato (Stephanolepisdiaspros). Da dati ancora preliminari, quindi non mi sbilancerei ancora tanto, sembra che sia in aumento la triglia del Mar Rosso (Upeneus pori), pescata recentemente nel catanese nella stessa zona dove fu segnalata per la prima volta nel 2017. Questa specie, in particolar modo, è facile che arrivi nei mercati, perché essendo molto simile alla triglia di scoglio (Mullussurmuletus) e di fango (Mullusbarbatus), che noi comunemente mangiamo, sicuramente passa spesso inosservata ai più. Quindi, molto probabilmente, è presente già in abbondanze superiori a quelle immaginate, ma semplicemente i pescatori e i consumatori non ci fanno caso. Ci sono magari, invece, casi in cui il pescatore si accorge che c’è qualcosa di strano, ma preso dal lavoro non pensa a comunicarlo a noi ricercatori e lo rigetta in mare.

- Triglia di fango sopra e triglia del Mar Rosso sotto (foto tratta dal video dei Fratelli Salamone dalla pagina facebook di Alienfish).
Che percezione hanno i pescatori di queste specie “strane”,che magari non hanno mai visto?
Per le specie ittiche non c’è ancora una grande percezione da parte del pescatore di questa invasione biologica. È un mare, più o meno, come è sempre stato, anche se certamente sta subendo dei cambiamenti. Infatti, alcune specie che prima erano più abbondanti, ora scarseggiano, come ad esempio la spatola (Lepidopuscaudatus) che in Sicilia era molto abbondante, soprattutto nel messinese, ora inizia a scarseggiare. Quest’ultima è una specie di interesse commerciale, non è una specie aliena. Mentre altre specie a carattere termofilo come il carango mediterraneo (Caranxcrysos) e il carango ronco(Caranxrhonchus), iniziano ad essere più abbondanti rispetto al passato. Per quanto riguarda gli invertebrati, attualmente c’è tantissima attenzione in tutto il Mediterraneo sul granchio reale blu (Callinectessapidus) e non parliamo di un lessepsiano, quindi proveniente dal Mar Rosso, ma di una specie aliena di origine atlantica. Noi, il 15novembre, abbiamo creato un evento che unisce cucina, tradizione e pesca e abbiamo portato proprio questo granchio in tavola grazie ad un notochef (Salvatore Gambuzza, detto Totò). Eventi di questo genere servono per far conoscere alle persone specie come il granchio reale blu, sia dal punto di vista ecologico, ma anche e soprattutto culinario. In questa maniera anche i pescatori sono più incentivati a catturarla e a venderla.
Mentre dal punto di vista economico, alla pesca quanto tange la presenza di queste specie aliene che stanno subentrando nei nostri mari?
Le specie aliene non sempre mostranoeffetti negativi immediatamente e facilmente misurabili.Caso particolare è quello del granchio reale blu. Qui abbiamo un effetto economico positivo ed un effetto ecologico negativo, perché comunque è una specie molto aggressiva nei confronti delle altre e può portare ad importanti squilibri ecosistemici. Considerate che questo granchio è ormai annoverato tra le 100 specie più invasive. Ma, d’altro canto, è anche vero che rappresenta in alcuni luoghi una risorsa economica in più per i pescatori e i venditori. Una domanda che ci siamo chiesti è: “Questa specie è da eradicare o no?” Perché se il suo valore commerciale aumenta, interesserà sempre di più al pescatore catturarla e venderla.
Però dal punto di vista ecosistemico è comunque una specie che crea danni, quindi è da eradicare, no?
Sì, secondo me, come tutte le specie aliene invasive, è una specie da eradicare, anche se in tutta probabilità l’unica cosa che per il momento possiamo fare è quella di limitare il danno che fa, pescandola sempre più. In Mediterraneo, ad oggi, l’eradicazione di specie aliene marine non ha mai avuto successo. Sarebbe un po’ come a voler eradicare le acciughe, le sardine, i saraghi o le triglie, che sono ovunque. Puoi tenerla sotto controllo, senza dubbio; puoi ridurne l’abbondanza, e in questo la pesca ci aiuta, ma non credo che si possa arrivare all’eradicazione.
Quindi dobbiamo imparare a conviverci. Prima però hai accennato alle specie termofile, come quelle specie che sono già presenti nella parte meridionale del Mediterraneo ma che, per l’innalzamento delle temperature, si stanno spostando anche nella parte settentrionale. Quali sono, anche in questo caso, le specie che possiamo trovare soprattutto nei mari italiani e in che abbondanza in base alla zona?
Possiamo trovare, come abbiamo già detto, ilcarango ronco o il carangomediterraneo, che sono specie che si pescano in maggior abbondanza rispetto al passato, soprattutto nelle coste meridionali d’Italia, ma non solo. Altra specie termofila è il pesce pappagallo o più correttamente noto come Scaro(Sparisoma cretense), che spesso viene erroneamente indicato come specie aliena. Ma già gli antichi romani conoscevano questo pesce, lo consumavano e lo importarono nelle acque laziali, dove addirittura imposero un divieto di pesca su questa specie. La sua abbondanza ha subito delle forti oscillazioni negli ultimi anni, attualmente viene pescata in grandissimi quantitativi qui in Sicilia, ma purtroppo non viene sfruttata adeguatamente. Anzi, in alcuni posti viene anche rigettata in mare perché non è considerata una specie pregiata, seppur commestibile.
Invece ora parliamo dal punto di vista del cittadino, che oltre ad essere sensibilizzato, magari può e vuole aiutare in qualche in modo. Prima, per quanto riguarda il progetto AlienFish, hai detto che vengono fatte molte segnalazioni dai cittadini. Ma, siccome voi non siete presenti in tutte le regioni, un cittadino a chi può segnalare la presenza di una specie aliena?
Fisicamente come Ente Fauna Marina Mediterranea non siamo presenti in tutte le regioni, nel senso che non abbiamo delegazioni in tutte le regioni, tuttavia abbiamo collaboratori in tutta Italia. Per il progetto AlienFish è presente una pagina web sul sito di Ente Fauna Marina Mediterranea, in cuitrovate tutti i contatti. Ma abbiamo anche un gruppo Facebook “Fauna Marina Mediterranea”,grazie al quale raccogliamo queste segnalazioni, e la pagina Facebook ufficiale del progetto AlienFish. Abbiamo anche creato una nuova locandina, aggiornata all’anno 2022, dove chi partecipa può trovare un indirizzo e-mail o un numero telefonico a cui inviare la segnalazione. A me spesso arrivano foto tramite Whatsapp di diverse specie interessanti. Pochi giorni fa ne abbiamo trovato uno molto raro su cui stiamo lavorando.

- Locandina 2022 del progetto AlienFish (Pagina Facebook di AlienFish).
Per curiosità, avete pensato anche alla possibilità di creare un’applicazione per raccogliere meglio queste foto o per poter facilitare l’identificazione della specie?
Assolutamente sì, ci abbiamo pensato. Probabilmente è una cosa che prima o poi faremo, ma è anche vero che abbiamo visto che il progetto nella sua forma attuale funziona molto bene. Questo perché, sostanzialmente, l’app già c’è ed è Whatsapp. Basta, quindi, fare una foto e inviarla con tutti i dati richiesti. Il bello delle specie aliene è che spesso cene possiamo trovare davanti una che non è mai stata segnalata in Mediterraneo. Proprio per questo motivo, sulla locandina abbiamo inserito un “pesce X” con il punto interrogativo, appunto per dire che va segnalata qualunque specie sospetta. Anche perché poi la validazione scientifica spetta a noi esperti, le uniche cose che ci interessano sono che la specie venga documentata almeno fotograficamente e alcune informazioni fondamentali sulla cattura, come la località precisa e la profondità. Quando possibile andiamo a recuperare l’esemplare, così da analizzarlo e da conservarlo nelle collezioni zoologiche presso l’Ateneo di Catania o dell’Ente. Quindi Whatsapp al momento va più che bene.
Abbiamo un’ultima domanda, siamo arrivati alla fine purtroppo. Secondo te, oltre alla pesca, esistono soluzioni che possano mitigare l’invasione delle specie aliene?O si andrà sempre più incontro ad una maggiore presenza di queste specie?
Io credo, in base a cosa ci dicono i dati, che l’ingresso delle specie aliene in Mediterraneo (che sono ormai più di mille) sarà un processo in costante crescita. La maggior parte delle specie non ha nessun interesse commerciale, oppure è molto scarso, quindi la pesca non è una soluzione per mitigare gli effetti dell’invasione biologica. A Cipro, ad esempio, intere squadre di subacquei vanno a caccia del pesce scorpione, togliendone dall’ambiente talvolta diverse centinaia al giorno. Sicuramente così tengono sotto controllo la popolazione della specie, ma non credo sia possibile in questa maniera raggiungere l’eradicazione della specie, che al massimo potrebbe essere strettamente locale e momentanea. L’unica cosa che possiamo fare è di aggiungere alla nostra cucina tutte quelle specie che possono essere consumate. Prevenire non si può, perché il Canale di Suez è ormai aperto da più di un secolo e mezzo. È possibile fare prevenzione su altri tipi di introduzione, come per le acque di zavorra che dovrebbero essereopportunamente trattate, così da impedire a larve e stadi adulti di specie aliene provenienti da altri mari, di colonizzare le nostre acque. Anche la sensibilizzazione degli acquariofili, che spesso liberano pesci tropicali in acque marine, può aiutare molto nella prevenzione. Ma rimedi riguardanti il Canale di Suez non sono applicabili.Addirittura, secondo un recente articolo di alcunicolleghi, ci sarà una colonizzazione dell’Atlantico delle specie aliene lessepsiane che oggi sono in Mediterraneo. Quindi almeno alcune diquelle specie che hanno già attraversato il Mediterraneo da est a ovest, probabilmente, giungeranno anche in Atlantico. Purtroppo, viviamo in un mare in costante cambiamento e che è destinato a cambiare ancora di più, a livello di biodiversità, fino a diventare un mare tropicale.
Senza alcun dubbio, quindi, dobbiamo rassegnarci, come già detto prima, a vedere sempre più specie diverse lungo le nostre coste. In un ambiente ampio come il mare, l’eradicazione di una specie è molto più difficile ed impossibile rispetto a quanto accade sulla terraferma. L’unica cosa che noi possiamo fare è aiutare progetti come AlienFish del dottor Tiralongo, attraverso l’invio di foto/video e alcune informazioni di base che verranno chiesti al momento della ricezione della foto. Chissà, magari un giorno potremo vedere Nemo a Napoli mentre Dory, purtroppo, è già arrivata…“Zitto e nuota, nuota e nuota. Noi che facciam? Nuotiam, nuotiam”.
Con queste ultime parole dell’amata pesciolina blu della Disney Pixar, noi vi salutiamo, sperando che anche questa intervista vi sia piaciuta e immaginando un mare sempre più invaso da alieni.
Archelon - Alieni del Mare
Alieni nel nostro Mare: organismi che arrivano da un altro pianeta?
Cosa si intende per “specie aliena”

- Scena film E.T.-L'extraterrestre, di Spielberg
Se vi dicessimo “pensate ad una specie aliena”, sicuramente il vostro primo pensiero andrebbe ad E.T. di Spielberg, nel caso dei più nostalgici, o a qualche specie del Multiverso della Marvel, nel caso dei più nerd. Ma le specie aliene, dal punto di vista scientifico, non riguardano niente di tutto ciò! Per “specie aliena”, infatti, si intende una specie animale, vegetale o microbica, che sicuramente non viene da un altro Pianeta, ma che viene così chiamata perché non è originaria del luogo in cui si trova. Queste specie rientrano nella categoria degli organismi invasivi perché molto spesso, nell’ambiente in cui vengono inserite, trovano le condizioni adatte per riprodursi e proliferare e, in questa maniera, invadere.
Come arrivano dove non dovrebbero arrivare
Ma come fanno queste specie ad arrivare in luoghi così diversi dai loro habitat di origine? Beh, le risposte sono tante e, come sempre, c’è lo zampino dell’uomo. Infatti, per definizione, per specie aliena si intende qualsiasi specie introdotta, in maniera deliberata o inconscia, dall’uomo.

2. Rappresentazione del Canale di Suez
Per esempio, uno dei motivi principali per cui nel Mar Mediterraneo vi ritroviamo specie come Rophilema nomadica, la medusa che può arrivare a pesare anche 50kg, è l’apertura del Canale di Suez. Si tratta di un canale artificiale (come quello di Panama) creato nel 1869 dal francese Ferdinand de Lesseps (si deve a lui, infatti, il termine lessepsiano, utilizzato per indicare la migrazione e le specie provenienti dal Canale). Questo canale ha permesso di unire direttamente il Mar Mediterraneo con il Mar Rosso, e quindi l’Oceano Indiano, senza circumnavigare l’Africa. Una grande opera! Ma quanto grande dal punto di vista ecologico? Non molto. Questo perché, tale collegamento, ha determinato un’apertura non solo al passaggio di navi ma anche di specie (eh sì, proprio le nostre specie aliene). Questo fenomeno, poi, è peggiorato quando, nel 2015, c’è stato un allargamento del Canale per permettere il transito contemporaneo di navi su ambo le rotte. Le specie che vengono introdotte da tale canale sono specie tropicali che, con l’aumentare delle temperature, trovano un ambiente sempre più favorevole per la loro proliferazione all’interno del Mar Mediterraneo.

3. Differenze tra prima e dopo i lavori di ampliamento
Un altro metodo attraverso cui alcune specie possono ritrovarsi addirittura nella parte opposta del mondo è il trasporto tramite le acque di zavorra. In questo caso, le specie trasportate rappresentano soprattutto microrganismi appartenenti al plancton ma anche organismi di piccole dimensioni ancorati saldamente agli scafi delle imbarcazioni, come le cozze.
Ma, cosa sono le acque di zavorra? Si tratta di una quantità di acqua che viene inserita nello scafo delle navi per poterle stabilizzare e che, una volta arrivate in porto, viene scaricata. Per molto tempo queste acque sono state scaricate senza problemi, senza essere a conoscenza dei clandestini che vi viaggiavano a bordo. Fu solo grazie allo scrupolo di uno scienziato olandese, GustaafHallegraeff, che si scoprirono gli organismi trasportati con le acque di zavorra. Le specie ad oggi diffuse in questa maniera sono numerose, prima tra tutte la cozza zebra, Dreissenapolymorpha, originaria del Mar Caspio, che oggi si trova al largo delle coste di diversi Stati, come Nord America, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e Svezia.
La capacità di diffusione di queste specie varia a seconda di diversi fattori. Il principale è la durata del viaggio: più le specie rimangono a lungo in queste acque, infatti, più si creerà una competizione o verranno a mancare le condizioni necessarie per la sopravvivenza.
Qual è il destino di queste specie?
Quasi sempre queste specie riescono a trovare le condizioni adatte per sopravvivere e, quasi sempre, riescono a trovare le condizioni per riprodursi. In quest’ultimo caso,da specie “di passaggio” si trasformano in specie “stabili”, ovviamente causando problemi. Ogni ecosistema, infatti, è regolato da delicati equilibri tra le varie specie, nel momento in cui si insedia una nuova specie questo equilibrio rischia di essere sconvolto. A volte, la nuova specie riesce ad introdursi senza fare troppi danni, occupando una nicchia ecologica vuota, ovvero occupando un ruolo nell’ecosistema libero. Ma con l’ingresso sempre più frequente di nuove specie gli ecosistemi sono messi fortemente a rischio.

- Mnemiopsisleidyi
Un esempio lampante è quello di Mnemiopsisleidyi, uno ctenoforo che spesso, in estate, stiamo cominciando a vedere nei nostri mari italiani, ma che è famoso per i danni che ha prodotto nel Mar Nero e nel Mar Caspio, dove ha determinato una riduzione dello zooplancton dell’80%.
Ormai, ridurre l’introduzione e l’espansione di queste specie è pressoché impossibile poiché, nonostante alcune misure contenitive (per esempio per le acque di zavorra è stato stabilito che devono essere debitamente trattate prima di essere introdotte in mare), il riscaldamento globale e la tropicalizzazione del Mediterraneo favoriscono sempre di più lo stabilirsi di queste specie.
Che cosa fare allora? Sicuramente continuare a monitorare queste specie è importante perché, studiandole, possiamo capire in che maniera possono interagire con le specie già presenti e che cambiamenti possono portare. A tal proposito, in Italia è presente il progetto Alien fish, che si occupa di raccogliere segnalazioni e monitora la presenza di queste specie nei nostri mari.
Inoltre, al momento, stanno prendendo piede alcuni progetti che prevedono la messa in commercio e la valorizzazione di queste specie aliene, favorendone il consumo sulle nostre tavole.

- Callinectessapidus
Un esempio molto importante è quello del granchio reale blu, Callinectessapidus, che ormai da diverso tempo ha colonizzato le nostre coste giungendo sin dall’Oceano Atlantico. Questo granchio è ormai diventato talmente frequente tra le reti dei pescatori di quasi tutta Italia che hanno iniziato a promuoverne il suo utilizzo nella cucina con eventi culinari che mostrano le diverse ricette da poter mettere in pentola.
Insomma, italiani aprite le vostre cucine all’ingresso di nuovi sapori, ma state attenti che non tutte le specie sono commestibili!
Sitografia:
- https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
- Pyšek, Petr, et al. "Scientists' warning on invasive alien species." Biological Reviews 95.6 (2020): 1511-1534.
- https://www.iucn.org/resources/issues-brief/invasive-alien-species-and-climate-change
- https://www.ilpost.it/2021/03/25/canale-suez-storia/
- Con il nuovo canale di Suez anche la 'maximedusa' di 50 kg Invasione di nuove specie nel Mediterraneo con l'ampliamento – ANSA.it – Ambiente&Energia
- https://www.corriere.it/ambiente/13_maggio_06/specie-aliene-navi-acqua-zavorra_4c19d500-b5b7-11e2-86df-caa1160f5c6a.shtml
- https://www.regionieambiente.it/balmas-un-progetto-per-limitare-il-rischio-di-specie-aliene-in-adriatico/
Archelon - LEK: Un Ponte tra la Scienza e i Pescatori
LEK: un ponte fra la scienza e i pescatori (e non solo)
Introduzione
Prima ancora di essere allevatore, l’uomo era cacciatore e non si limitava a cacciare solo animali terrestri ma anche le forme di vita che popolavano il mondo sottomarino.
Dapprima, fin dal Paleolitico, con il semplice utilizzo delle proprie mani l’uomo ha praticato l’arte della pesca, specializzandosi poi sempre di più costruendo strumenti come ami, reti, arpioni.

- Rappresentazione egiziana dell’attività di pesca.
Con il passare dei secoli, l’uomo si è evoluto e così anche la pesca: strumenti sempre più efficienti sono stati costruiti, il mercato si è espanso sempre di più, fino a diventare globale. Al centro di questa evoluzione, le figure protagoniste di questo cambiamento sono sempre stati i pescatori, persone che trascorrono la maggior parte del tempo in mare, e che si può dire rappresentino coloro che meglio conoscono il mondo marino. Se vi sono dei cambiamenti, infatti, sono i primi ad accorgersene proprio perché vivono il mare tutti i giorni.
Ciò nonostante, per molti anni la comunità scientifica non ha tenuto conto di questa importante risorsa. La scienza, infatti, ha sempre teso ad essere un mondo a parte, quasi elitario, in cui perfino la divulgazione dei risultati delle ricerche e delle scoperte era riservata ai soli appartenenti al mondo scientifico. Si trattava di scienza per la scienza.
Negli ultimi decenni, però, qualcosa è cambiato. L’impatto antropico e i cambiamenti climatici hanno portato numerosi effetti sugli ecosistemi, soprattutto su quelli marini. Cambiamenti in temperatura, salinità e altri parametri, hanno determinato la perditadibiodiversità, l’introduzione di specie in determinati habitat e hanno influenzato la stabilità e la resilienza degli ecosistemi. Tutto questo è stato monitorato e continua ad essere monitorato nel tempo grazie a campagne in mare e campionamenti per la raccolta dati. Purtroppo, però, spedizioni e campionamenti hanno un costo e, per questo motivo, non è possibile svolgerli con una certa frequenza. Ed è qui che è subentrata la LEK.
Cos’è la LEK
Data l’impossibilità di poter svolgere un monitoraggio continuo nel tempo, la comunità scientifica ha imparato ad utilizzare in maniera scientifica tutte quelle informazioni ecologiche in possesso delle comunità locali, che, nel caso del mare, sono rappresentate dai pescatori. Questo tipo di approccio viene definito Local Ecological Knowledge (LEK), ovvero “conoscenza ecologica locale”. Infatti, seppur di impronta non accademica, i pescatori sono una fonte di conoscenza ecologica inimmaginabile. Quando sono arrivati i primi esemplari di specie non indigene in Italia, i primi ad accorgersene sono stati i pescatori, che ritrovavano nelle reti pesci mai visti prima. Quando è cominciato il calo di alcuni stock ittici, sono stati sempre i pescatori a rilevarlo per primi, perché ritornavano a casa con reti sempre più vuote. Questo tipo di approccio, quindi, permette di determinare la presenza o meno di determinate specie e di ricostruire il trend di abbondanza delle specie di interesse commerciale e anche di determinarne la variabilità nelle taglie di cattura.

- Locandina dell'Ente Fauna Marina Mediterranea sul progetto AlienFish, ovvero sulle catture delle specie aliene nel Mediterraneo.
Questo tipo di procedura, però, può essere soggetto a errori dovuti alla soggettività delle informazioni che possono essere imprecise per via delle influenze culturali e geografiche, ma anche per caratteristiche come età, sesso, personalità degli intervistati o addirittura per la stessa interazione di chi intervista con l’intervistato che può, in alcuni casi, influenzare le risposte. Nonostante ciò, se tutte queste variabili vengono tenute in considerazione al momento dell’elaborazione dei dati, questo tipo di informazioni possono assumere un’importanza di un certo rilievo. Sempre più studiosi, infatti, stanno integrando questo tipo di raccolta dati con le più classiche tecniche di monitoraggio.
Inoltre, questo approccio non permette solo un’acquisizione maggiore di informazioni, ma permette di stabilire un legame tra scienziati e pescatori, un vero e proprio ponte che unisce due mondi e che migliora il dialogo tra essi, determinando una sinergia che potrebbe portare ad una migliore gestione delle risorse ittiche e delle problematiche ambientali di origine antropica.
É importante riuscire ad estendere questo tipo di approccio anche al resto dei cittadini, non solo ai pescatori. L’importanza della scienza è che venga condivisa, divulgata, perché solo in questa maniera si può andare veramente verso il cambiamento e verso la risoluzione delle problematiche che affliggono il nostro Pianeta. Infatti, per questo motivo, ci sono sempre più progetti scientifici che prevedono lo sviluppo di app per il monitoraggio o di attività divulgative che permettano il confronto tra scienziati e cittadini e uno scambio di informazioni.
Sitografia:
- The value and limitations of local ecological knowledge: Longitudinal and retrospective assessment of flagship species in Golfo Dulce, Costa Rica - https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.10219
- Fishers’ Local Ecological Knowledge (LEK) on Connectivity and Seascape Management - https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00130/full
Intervista a Adrishark. La Voce degli Squali
Adrishark- la voce degli squali.
Cos’è la prima cosa che vi viene in mente quando si parla di squali?
Probabilmente la maggior parte di voi penserà al Carcharodon carcharias, ovvero lo squalo bianco (o grande squalo bianco), divenuto famoso soprattuttodopo il film di Spielberg del 1975 Lo squalo (in lingua originale Jaws). Non solo, forse alcuni di voi pensano agli squali come organismi lontani da noi, dal mar Mediterraneo. Eppure, non è così.
Per questo motivo, dopo l’articolo uscito qualche giorno fa su alcune delle minacce che colpiscono proprio questi animali, abbiamo deciso di intervistare Laura Piredda, conosciuta come Adrishark su instagram. Proprio attraverso questo social, infatti, Laura cerca di trasmettere una visione diversa degli squali.

- Laura Piredda, alias Adrishark.
Ciao Laura,cosa è Adrishark e perché questa passione per gli squali?
Gli squali hanno sempre fatto parte del mio mondo, anche se da piccola non amavo il mare. Odiavo l’acqua, davvero, poi crescendo qualcosa è cambiato. Guardando i film sugli squali, gli stessi su cui ora cerco di sfatare i miti, io facevo il tifo per loro. Ero lì, davanti lo schermo e dicevo “forza, mangiala quella persona!”. Successivamenteho iniziato a capire che, attraverso la televisione e il grande schermo, lo squalo veniva demonizzato. Per questo motivo ora cerco di fare ciò che posso a riguardo. Adrishark è nata ormai due anni fa, nell’aprile 2020, con il desiderio di fare vedere gli squali diversamente. Spero, inoltre, di far diventare Adrishark un vero e proprio progetto scientifico. Quindi incrocio le dita a riguardo. Attualmente, invece, sto per laurearmi ad un master sui grandi vertebrati marini con un progetto di tesi sullo sviluppo embrionale dello squalo zebra in cattività.
Buona fortuna allora con tutto, sia per la tesi che per i tuoi progetti!È bellissimo, però, immaginarti mentre facevi il tifo per gli squali. Comunque, noi sull’articolo abbiamo parlato soprattutto dello sharkfinning, ma ci sono molti più problemi che colpiscono gli squali. Uno tra questi è la frode alimentare, che tratti molto sul tuo profilo. Quindi, cosa puoi dirci a riguardo?
Purtroppo,la frode alimentare è un problema a livello globale,accade anche in Italia e con tutti i prodotti alimentari. Per quanto riguarda gli squali, ci sono vari problemi che concernono la vendita. A partire dal nome, nel senso che si usa lo stesso nome per indicare più tipi di squali, oppure vendere un pesce spada che in realtà è uno squalo. Nel settore ittico e della commercializzazione di tutto il mondo, esistono diversi nomi per indicare gli animali, designati da enti o organizzazioni. Il problema dove sta? Prendiamo ad esempio lo squalo mako dalle pinne corte (che troviamo tipicamente nei supermercati),il suo nome scientifico è Isurus oxyrinchus, ma sulle etichette spesso ci trovi scritto anche “mako o smeriglio”, addirittura alcune volte anche solo “smeriglio”. Eppure, lo smeriglio è il nome comune di un altro squalo, ovvero il Lamna nasus, che è completamente diverso dal mako. Questo ovviamente comporta una mal identificazione della specie, che invece è importante.
Cosa si può fare, quindi, per evitare la frode alimentare?
Come prima cosa, bisogna sempre chiedere. Ma non solo per quanto riguarda la frode legata agli squali, mi riferisco ad ogni tipo di prodotto. Non fermatevi, magari, all’etichetta dove alcune informazioni possono mancare. Chiedete sempre! Per il trancio di pesce che ti vendono ai ristoranti o in pescheria, basta riuscire a farci l’occhio. Il trancio del pesce spada e quello di squalo sono molto simili, ma se avete la possibilità di porre i due pezzi accanto potete notare effettivamente le differenze. Come ad esempio il colore, che nel pesce spada è più chiaro e ha una linea scura a forma quasi di un tre che è il muscolo rosso. Invece lo squalo è molto più scuro e il muscolo rosso somiglia più ad un pallino o un triangolino sempre nero. Un’altra cosa che potrebbe aiutare è toccare la pelle, che nel pesce spada è liscia mentre nello squalo è ruvida.
- Trancio di pesce spada a sinistra e di smeriglio a destra.
Oltre allo sharkfinning e la frode alimentare, quali sono gli altri problemi che minacciano gli squali ma che sono poco conosciuti?
Le minacce sono davvero tante, come ad esempio la pesca. Tra l’altro il finning è ormai diventato relativo, grazie alla forte sensibilizzazione che vi è stata negli ultimi anni. Adesso lo squalo bisogna portarlo a terra, intero, e solo lì puoi togliergli le pinne. Questo però ha contribuito ad una maggior commercializzazionedella carne di squalo. I pescatori, ovviamente, non potendo più buttarlo in acqua una volta pescato, lo vendono. Di conseguenza, vi è stata una maggior richiesta di questo prodotto da parte del consumatore. Non dovete, però, immaginarla come una realtà lontana, magari solo dei Paesi asiatici. Il consumo di squalo sta diventando sempre più usuale anche in Europa, come in Italia, Spagna, Francia, ecc. Altri problemi sono ad esempio il bycatch o anche l’assenza della taglia minima di cattura. In questo ultimo caso vi è l’aggravante dell’estrema lentezza degli squali nel diventare maturi sessualmente. Alcuni squali ci mettono 16/20 anni prima di potersi riprodurre. Ciò vuol dire che si pescano squali ancora piccoli, che magari non si sono mai riprodotti nemmeno una volta e la conseguenza è la diminuzione delle varie popolazioni. Ci sono però diverse istituzioni, come l’ICCAT, che si occupa di tonni ma anche di squali, che ha inserito delle quote di pesca (ciò significa che hai un numero limitato di mako o verdesca che puoi pescare). Purtroppo, questo non basta e nel Mediterraneo molte specie di squalo stanno sparendo. Fino a qualche anno fa, ad esempio, nel sud del mar Mediterraneo si potevano vedere gli squali martello, ora non più.
Questo, ovviamente, comporta problematiche anche di tipo comunicativo.
Assolutamente sì. Infatti, moltissimi giornali spesso scrivono degli articoli con un titolone del tipo “Uno squalo è stato avvistato in Sicilia”, o in qualsiasi altro luogo. La mia reazione potete immaginarla. Voglio dire: è uno squalo che nuota e, sì, sta anche nel Mediterraneo. Stanno diminuendo, ma loro vivono nel mare, di qualsiasi parte del mondo. Oppure ci sono quei titoli del tipo “Squalo attacca o preda una persona”, no, non è così. Lo squalo non vuole predare l’uomo perché non faparte della sua dieta, non è la sua preda target.
Purtroppo, è vero. Capita anche a noi quando, ad esempio, diciamo che lo squalo bianco vive anche qui nel mar Mediterraneo, spesso le persone rimangono sconvolte perché vedono questi animali come appartenenti più a mari tropicali o diffusi in America o Australia. Secondo te, quindi, perché c’è tutta questa disinformazione sugli squali?
A proposito di questo, nel mar Mediterraneo ci sono più di trenta specie di squalo, ma ovviamente non te li ritrovi davanti mentre nuoti. Gli squali preferiscono starsene per fatti loro in zone più a largo. Quando lavoravo all’acquario di Malta io chiedevo ai turisti “Ma secondo voi ci sono gli squali nel nostro mare? Intorno a Malta, l’Italia, la Grecia?”. Loro mi rispondevano tutti “no” e da lì iniziava la paura nello scoprire invece il contrario. Con calma, poi, io spiegavo loro le caratteristiche degli squali, della pesca o del finning e dei film che invece li mostrano come antagonisti, figure negative. Allora mi piace far immaginare un mondo parallelo dove, al posto del film sullo squalo, ci stava un film su un delfino assassino, che uccideva tutti. Immaginatelo anche voi! A quest’ora tutti quanti avremmo paura dei delfini e non degli squali. Ci sono varie considerazioni da fare, ovviamente. I film sono un problema, ma in maniera relativa. Io ricordo che quando ero piccola, ci stava un film su delle api modificate ed assassine ma non c’è ora una vera e propria demonizzazione di questi insetti. Sugli squali, invece, c’è stato un effetto molto più impattante! Io vi dico che, se fossi una naufraga in mezzo all’oceano, in primis avrei assolutamente paura. Infatti, sia chiaro, non dico alle persone che non devono avere paura degli squali, bisogna tenere in mente che sono comunque predatori, ma questo non vuol dire che ti attacchino per forza. Bisogna sempre pensare che quando siamo in mare è come se stessimo su un altro pianeta, non è il nostro habitat; quindi, è giusto stare sempre in allerta. Non solo con gli squali, anche con delfini o balene. È necessario sapere come comportarsi in acqua, sia che fai snorkeling, diving o nuoto. Poi, come dicevamo prima, c’è un forte problema di comunicazione. Spesso l’attacco da parte di uno squalo viene amplificato molto dai media, ma sono degli eventi davvero molto rari e sporadici.
Deve essere una paura razionale, come per tutto.
Sì, senza dubbio. Anche perché le persone spesso poi, capendo la realtà degli squali, reagiscono di conseguenza. Mi sono trovata spesso persone che poi si emozionavano o piangevano quando parlavo del finning e uscivano da lì dicendomi che avrebbero fatto più caso poi nelle pescherie, proprio per cercare di evitare di comprare carne di squalo. Purtroppo per la conservazione degli squali la situazione è un po’ difficile, importante è parlare con i pescatori. In alcune zone, come ad esempio a Malta, si usa andare nelle pescherie per salvare le uova e portarle in acquario.
C’è tanto da fare, purtroppo. Non è facile tutelarli proprio perché molte persone, a causa della paura che ne hanno, non vogliono farlo.
Sì, ad esempio in Australia ci sono vari problemi da moltissimi anni. In pratica hanno messo in mare delle reti molto lunghe con degli ami pieni di cibo, fatte per tutelare surfisti e bagnanti. Il problema è che ci stanno finendo balene, squali zebra (che sono del tutto innocui), delfini, tartarughe. Eppure,non catturano gli squali bianchi, ovvero la specie per cui avevano messo tali reti. È uscito un documentario a riguardo che si chiama “ENVOY film”, le persone spesso riprendono quello che accade proprio per denunciare il tutto. Vogliono far capire al mondo quello che accade! Inoltre, una persona comune non può andare lì a toglierle perché rischi di danneggiarle e, non solo, puoi essere anche arrestato o ricevere delle multe per un’azione del genere. È successo qualche anno fa che, appunto, una persona ha cercato di salvare una balena che era rimasta impigliata nella rete ed è stata multata. Per non parlare della pesca ricreativa che fanno in America, catturano tantissimi squali perché non sono animali tutelati. Anzi, vengono anche pagati in alcune zone per farlo. Per loro, lì è tutto legale, anche uccidere uno squalo con un coltello in testa dopo averlo trascinato sulla spiaggia e averci “giocato”. Se cercate “shark tournament” vedrete di cosa sto parlando. Noi però dobbiamo continuare a fare quello che facciamo: comunicare, divulgare, diffondere il più possibile ciò che sappiamo. È tosta e davvero difficile e non la vedo molto rosea per questi poveri animali, ma noi non dobbiamo mollare!
“Non dobbiamo mollare”, parole bellissime dette con il desiderio di vedere un mondo diverso. Tutto dipende da noi. Impariamo ad informarci, a domandare, a mettere in dubbio ciò che abbiamo sempre pensato. Gli squali sono animali importanti, sotto tutti i punti di vista, ed è possibile scoprire il loro mondo andando oltre l’immaginario comune. Guardatevi, anzi guardiamoci intorno, alla ricerca di persone come Laura che possono aprirci gli occhi su una realtà tanto diversa da quella che conoscevamo. Ascoltiamole e, soprattutto, ascoltiamo questo mondo che grida “aiuto”.
Noi, come sempre, cercheremo di fare del nostro meglio per diffondere notizie come queste.
Adrishark è una ragazza semplice, solare, anche molto timida e, soprattutto, è la voce degli squali. Continua così, noi ti auguriamo di vedere realizzato ogni tuo desiderio e progetto. In bocca al lupo… anzi, in bocca allo squalo.
Archelon - Shark Finning
Sharkfinning: una pratica barbara
Premessa
Da quando ha fatto la sua uscita sul grande schermo il noto film “Lo squalo”, di Steven Spielberg, lo squalo viene visto come un animale terribile, divoratore di uomini. Questo “semplice film” ha dato il via ad un vero e proprio processo di demonizzazione di tutti gli squali che, rispetto ad esempio alle zanzare, sono da considerare addirittura principianti in termini di numero di morti umane.

- "Lo squalo" di Steven Spielberg
Purtroppo, però, i problemi degli squali non si limitano all’ essere visti come macchine assassine. Ciò che affligge gli squali ormai da anni è la loro pesca incontrollata. Pensate che ogni anno ne vengono pescati quasi 100 milioni di esemplari. Per darvi un’idea, questo numero corrisponde a quasi due volte gli abitanti dell’Italia. La cosa più triste è che questi pesci vengono pescati per lo più per il “finning”, detto anche spinnamento.
In cosa consiste lo “sharkfinning”
Lo spinnamento degli squali è una pratica antica, originaria della Cina dove, durante i banchetti dei più ricchi, veniva servita la famosa zuppa di pinne di squalo, ritenuta afrodisiaca e ottima per la salute. Purtroppo, con il passare degli anni ed il boom economico, questa zuppa è diventata alla portata di molti, causando così un aumento della richiesta di pinne di squalo (che possono arrivare ad un prezzo di 1.000 euro l’una) e quindi dello sharkfinning.
- Pratica dello shark finning e zuppa di pinne
Questa pratica non si è fermata all’ Oriente, ma si è estesa anche al mondo Occidentale, dove Spagna, Portogallo e Francia figurano tra i primi 15 Paesi al mondo nella cattura di squali. L’Italia di certo non è da meno, poiché registra all’anno 10.000tonnellate di carne di squalo importata, classificandosi al terzo posto della classifica mondiale. Questo perché, anche se non saremo amanti della famosa zuppa di pinne di squalo, siamo sicuramente soggetti ad un altro grande problema: la frode alimentare, un problema in cui molte volte la carne di squalo viene spacciata per altro (es. pesce spada).
Ma come avviene lo spinnamento? Questa pratica consiste nel pescare gli squali, staccar loro le pinne dorsali e ventrali (a volte anche le caudali) e rigettarli in mare. Ciò per avere maggior spazio a bordo e poter stipare sulla nave il maggior numero di pinne possibile. Questo, oltre ad essere un atto barbaro è anche crudele e disumano, poiché l’animale, ancora vivo, non può più nuotare e, di conseguenza, respirare, morendo così in sofferenza.
Quali sono le ripercussioni sugli ecosistemi marini?
Questa pratica, oltre a colpire gli squali, colpisce di riflesso anche gli ecosistemi in cui essi vivono. Infatti, essendo gli squali dei predatori apicali, ovvero a capo della rete alimentare del mare, costituiscono una regolazione dei livelli più bassi, rappresentati da razze, specie più piccole di squali, ostriche, capesante, etc. Nel momento in cui questi vengono a mancare, si creano squilibri a tutti gli altri livelli della rete trofica, come un vero e proprio effetto domino.

- Schema di una rete alimentare
Purtroppo, la situazione è veramente tragica. Dagli anni 70’, infatti, il 71 % di razze e squali è in declino e metà delle specie di squali presenti si trovano a rischio o criticamente a rischio estinzione.
Come si prospetta il futuro?
Il futuro che si prospetta, per questo e mille altri motivi, non è dei più rosei, anzi. C’è però chi lotta per la protezione di questi preziosi animali. Nel 2013, infatti, è nato il regolamento “Fish Naturally Attached”, che prevede che gli squali catturati vengano mantenuti integri fino allo sbarco, solo dopo di questo le pinne possono essere staccate dal resto dell’animale. Purtroppo, però, sono molti coloro che operano illegalmente e che continuano a staccare le pinne a bordo e a gettare la carcassa in mare. Inoltre, questo regolamento, non si pone in un’ottica conservazionistica.
Per questo motivo è nato Stop finning- stop the trade, un’iniziativa nata dai cittadini europei per fermare il massacro degli squali e il commercio delle loro pinne. Si tratta di una petizione che ha come scopo quello di cambiare la legislazione europea in merito al commercio degli squali, dal momento che la sola Europa rappresenta uno dei principali esportatori di pinne ed un importante centro di transito.
4. Marchio iniziativa Stop finning EU (europa.eu)
BIBLIOGRAFIA:
Archelon - Strumenti di Pesca: le Nasse
Strumenti da pesca: Le nasse
Uno dei lavori più antichi è quello del nassarolo, ovvero del pescatore con le nasse. Probabilmente già dai tempi degli antichi romani questi strumenti da pesca venivano utilizzati per catturare polpi e pesci. Questo è un tipo di pesca tradizionale, protagonista soprattutto delle marinerie del sud Italia e dell’Adriatico.

- Immagine con le forme più antiche di pesca (III secolo d.C. - Sousse Museo Archeologico)
La nassa è uno strumento che tradizionalmente veniva costruito a mano in giunco, corde e rami di ulivo. Ad oggi le nasse si trovano soprattutto in materiale plastico o metallico: attualmente, infatti, sono pochi i nassaroli che costruiscono le nasse manualmente soprattutto perché le nasse in plastica sono più maneggevoli, resistenti, di facile e rapido acquisto.
Che cosa sono le nasse?
Le nasse sono vere e proprie trappole mobili che vengono calate sul fondale per catturare diverse specie e possono variare per dimensioni e forma in base alla specie target.
2. Diversi tipi di nasse in plastica e metallo
In pratica, se desideriamo catturare delle aragoste, le nasse più usate sono quelle di grandi dimensioni con forma a campana. Le nasse destinate ad alcuni tipi di pesce o alle seppie sono invece più piccole e presentano all’interno esche o rametti di alloro che attirano le femmine durante il periodo di riproduzione. Questa, per le seppie, è infatti una tecnica piuttosto furba perché, attirando le femmine, spesso arrivano all’interno della nassa anche i maschi. Ma perché proprio il rametto di alloro? Ve lo spieghiamo subito! È stato notato che le femmine entrano nelle trappole attratte proprio da questi rametti, attorno a cui poi verranno deposte le uova.

- Rametto di alloro con uova di seppia.
Le uova vengono deposte anche intorno alla nassa stessa anche se purtroppo molto spesso, durante l’azione di pulizia di questi strumenti da pesca, vengono colpite da un getto d’acqua molto forte e buttate in mare.
Come si pesca?
Il nassarolo cala sul fondale le nasse con all’interno diverse esche che attirano crostacei, pesci o molluschi. Le nasse, legate tra loro, vengono calate al tramonto e una zavorra le mantiene sul fondo.

- Schema della pesca di granchi con le nasse (www.msc.org)
In superficie, invece, boe o bandiere ricordano al pescatore la zona dove sono state lasciate. All’alba, infatti, il nassarolo torna in mare e ritira le nasse con tutto il pescato.
Nonostante le nasse siano uno strumento piuttosto selettivo nel mondo della pesca (questo significa che tendono a catturare solo le specie target), il lavoro del nassarolo sta scomparendo piano piano, soppiantato soprattutto dal pescatore con reti a strascico, pratica che risulta essere più comoda e redditizia. In Atlantico, però, vi è ancora spazio per questo lavoro, dove i nassaroli, per pescare il granchio reale o altri crostacei, spesso ci rimettono la vita per via delle condizioni avverse del mare
Sitografia:
- https://www.msc.org/what-we-are-doing/our-approach/fishing-methods-and-gear-types/pots-and-traps
- https://www.ilgiornaledeimarinai.it/la-pesca-con-le-nasse/
- https://www.portofinoamp.it/attivita-tradizioni/le-origini-della-pesca
Accordo tra Tartamare e il Centro Ricerche Cetacei Delphin
Grandi novità!!!
È stato siglato l'accordo tra Tartamare e il Centro Ricerche Cetacei Delphin.
Il progetto sarà sviluppato seguendo due linee di azione.
La prima prevede il coinvolgimento dei diportisti che durante l'estate dovessero incontrare cetacei o tartarughe marine.
Avranno a disposizione una piattaforma informatizzata in cui inserire gli avvistamenti con tutti i dati necessari per la ricerca.
La seconda prevede l'organizzazione di uscite in barca a vela per il monitoraggio, in cui i volontari potranno aiutare i ricercatori a raccogliere direttamente in mare i dati biometrici e comportamentali dei cetacei e delle tartarughe marine presenti nell'arcipelago toscano.